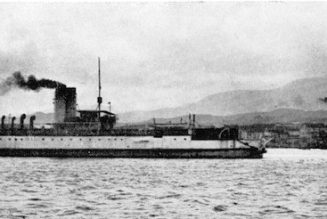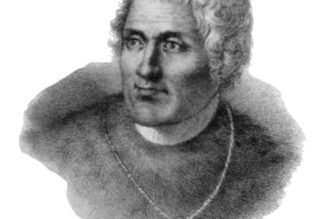L’Ottocento è un secolo entusiasmante perché ricco di scoperte e pieno di vive contraddizioni, diviso fra un settecento riformista e un novecento avanguardista, fra i vecchi privilegi di classe e l’avanzare dello stato di diritto, tra la vecchia ricchezza della terra e la nuova ricchezza delle pubbliche amministrazioni, dei servizi pubblici, della tecnologia al servizio dell’uomo.
 Non solo: l’Ottocento è un secolo creativo, internazionalista, che apre le porte al forestiero e per questo s’organizza, ponendo le basi della società attuale con nuove vie di comunicazione tra il centro e la periferia, i grandi luoghi d’ospitalità come gli alberghi, i teatri, i caffè, le biblioteche, le scuole e i luoghi della gestione del tempo libero, come i musei, i giardini, le fontane, i monumenti, i viali.
Non solo: l’Ottocento è un secolo creativo, internazionalista, che apre le porte al forestiero e per questo s’organizza, ponendo le basi della società attuale con nuove vie di comunicazione tra il centro e la periferia, i grandi luoghi d’ospitalità come gli alberghi, i teatri, i caffè, le biblioteche, le scuole e i luoghi della gestione del tempo libero, come i musei, i giardini, le fontane, i monumenti, i viali.
MESSINA nell’Ottocento
Messina negli anni ’60 è una grande città. In tutto il meridione ce ne sono solamente altre due con più di 100.000 abitanti: Napoli a Palermo[1]. In vent’anni la popolazione cresce a dismisura e a un tale sviluppo demografico non corrisponde un adeguato sviluppo urbano e mentre Napoli e Palermo operano sventramenti, Messina si estende sulla pianta della vecchia città, senza compiere una vera e propria opera di razionalizzazione del territorio urbano[2].
Il perchè è ravvisabile nelle ferventi polemiche, sorte all’interno del consiglio comunale, per la stesura di un piano regolatore adeguato alle direttive del governo unitario. Nell’attesa di un piano definitivo, si mettevano in pratica «piani d’arte» ad hoc che riproponevano i contenuti dell’elastico piano regolatore borbonico del 13 aprile 1859 [3]. Da qui anche un’irregolare crescita architettonica della città, dove tutti potevano costruire tutto, in barba alla legge nazionale.
La città s’arricchisce di Esposizioni internazionali di Belle Arti (1839, 1882, 1900), mentre partecipa attivamente a quelle di Napoli del 1855, a quella universale di Parigi dello stesso anno, di Torino e di Milano del 1881 e del 1887, di Palermo del 1891-92, per citare solo quelle più importanti.
Furono queste le grandi vetrine dei validi artisti locali, come i pittori Letterio Subba, Michele Panebianco, Giacomo Conti, Dario Querci e degli scultori Gregorio Zappalà, Gaetano Russo, Giovanni Scarfì (di cui scopriamo un interessante rapporto con lo scultore palermitano Mario Rutelli), ma anche della borghesia messinese che si mostrava al pubblico europeo, e di oltreoceano, con case grandi e bellissime, ricche di quadri e di sculture, così come scopriamo con la visita del re Umberto I e della sua consorte.
Messina viveva di piccole e medie attività imprenditoriali e di molto artigianato: una città a misura di borghese visto che il borghese è il maggior consumatore di beni superflui.
Le attività imprenditoriali a Messina nell’Ottocento
| Ebanista | Mortillaro Salvatore |
| Ebanista (2) | Calascione Stellario, Cangeri Giovanni |
| Fabbricante di Busti di donna (2) | Palumbo Felice, Palumbo Vincenzo |
| Fabbricante di Cappelli (2) | Arcidiacono Giuseppe, Visco Girolamo |
| Fabbricante di Cappelli (2) | Quattrocchi Giuseppe, Ragona Carmelo |
| Fabbricanti di guanti (1) | Dotto Vedova di Antonio |
| Fabbricanti di Guarnimenti di carrozze (3) | Bonaccorso Paolo, Carrozza Domenico, De Cola Vincenzo |
| Fabbricanti di Oggetti d’oro (3) | Caizzone Vito, Cara Antonio, Carnazza Antonio |
| Fabbricanti di Oggetti d’oro (7) | Cotugno Basilio, Crisafulli Giuseppe, Frassica Paolo, Lo Giudice Candido, Ponzio Salvatore, Sergi Giovanni, Zodda Michele |
| Incisore | Benincasa prof. Giovanni |
| Incisore | Minasi Antonino |
| Mercanti Sarti (6) | Bella Domenico, Bongiovanni Antonio, Bossa Domenico, Cotugno Letterio, Magno Antonio, Provvidenti Angelo, |
| Modisti e modiste (6) | Bertini Antonina, Coglitore Francesco, Detullio Ferdinando, Gentile Sebastiano, Savasta Giuseppa, Villari Anna |
| Negoziante Banchiere | Fratelli Fischer |
| Negoziante di oggetti d’oro (11) | Aliotta Carmela, Andronico Alessandro, Benigni Vincenzo, Bruno Luigi, Crisafulli Giuseppe, Erbicelli Concetta, Farsetti Giovanni, Lo Giudice Candido e Vincenzo, Oliva Francesco, Prestopino Gaetano, Savoia Antonio |
| Negoziante di oggetti d’oro (3) | Cara Antonio, Sorropago Lucio, Talamo Michele |
| Negoziante di prodotti (3) | De Pasquale Simone e fratelli, Polimeni Francesco Saverio, Rizzo Antonino |
| Negozianti di grani | De Martino Tommaso e figli, De Natale Tommaso e fratelli, Mauromati F. G. di Demetrio |
| Venditori di Cuoiami | Trombetta Antonino, Lanza, Ainis |
È un’Ottocento in cui si fa strada, con il positivismo, la mentalità borghese.
La borghesia italiana: la rivoluzione tradita
I personaggi che la popolano sono intellettuali cosmopoliti, ex rivoluzionari che si spostano da una parte all’altra della penisola, si scambiano opinioni, criticano, contestano.
Nel mio lavoro mi sono servito più volte di loro, sono uomini che vogliono una parte attiva nella società, che chiedono la certezza del diritto.
Insieme a loro e contro di loro si muove parallela una classe sociale emergente, più nota con l’accezione di piccola borghesia, fatta di avvocati, notai, procuratori legali, medici, farmacisti, agrimensori, ingegneri, liberi professionisti rampanti che trovano ampi spazi nell’amministrazione locale, nei consigli comunali, provinciali, nei tribunali, nella camera di commercio e da dove coordinano la propria attività economica. Queste caratteristiche, comuni, come ci conferma Carlo Cattaneo[4], a tante città italiane, sia settentrionali che meridionali, sono il fattore unificante del tessuto culturale italiano, insieme a quella classe d’intellettuali ex rivoluzionari che avevano lanciato un entusiasmante ponte di collegamento culturale e politico fra le maggiori città d’Italia e le grandi capitali europee.
Questi uomini riescono dove i loro padri avevano fallito con la rivoluzione. E riescono non imbracciando forconi o fucili, non con le barricate, ma utilizzando un sistema tanto semplice quanto efficiente: la legge.
L’imperativo categorico è sottrarre la terra e le proprietà immobiliari alla borghesia agraria.
[1] É la terza città del meridione per numero d’abitanti, dopo Napoli e Palermo. Da C. Carozzi-A. Mioni, L’Italia in formazione, Bari 1970. Cfr. G. Galasso, Lo sviluppo demografico del Mezzogiorno prima e dopo l’Unità, in Id., Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1965, pp. 303-441.
[2] Collegio degli Ingegneri ed Agronomi, Sul risanamento di Messina, Tip. Filomena, Messina 1886, pp. 69-70.
[3] ACC, tornata del 24 marzo 1865, deliberazione n. II: Espropriazione della casa Toro per la continuazione della via Policleto. L’espropriazione venne effettuata ai sensi del piano regolatore 13 aprile 1859, pp. 24-25. È la prima dopo la pubblicazione della legge nazionale sull’edilizia urbana.
[4] Carlo Cattaneo, Notizie naturali e civili su la Lombardia – La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, a cura di Franco Livorsi e Robertino Ghiringhelli, Oscar Mondadori, Milano 2002.